C’è un filo sottile che unisce il saper leggere un bilancio, comprendere un tasso d’interesse o distinguere tra un investimento sostenibile e una truffa online: la capacità di prendere decisioni consapevoli. È questa la vera essenza dell’educazione finanziaria — o edufin, come sempre più spesso viene chiamata — che oggi le istituzioni internazionali riconoscono come una competenza di cittadinanza a tutti gli effetti.
Edufin a scuola: perché è importante
Secondo l’OCSE, l’alfabetizzazione finanziaria è una life skill necessaria per navigare in un mondo economico complesso, caratterizzato da scelte quotidiane su credito, risparmio, consumo e sicurezza digitale. Non si tratta di formare esperti di finanza, ma di educare cittadini capaci di orientarsi tra opzioni economiche, comprendere le conseguenze delle proprie scelte e costruire una relazione sana con il denaro.
Per il G20 e per la rete internazionale OECD/INFE, le scuole sono il luogo più adatto per cominciare questo percorso: “Le scuole – si legge nel report OECD del 2014 – sono il luogo ideale per ridurre il divario di competenze finanziarie prima che si traduca in divari sociali”. L’educazione finanziaria non è, dunque, un lusso o una materia opzionale, ma un fattore di inclusione: una leva per la giustizia economica, la resilienza sociale e la partecipazione democratica.
In Italia, la legge 15/2017 e le Linee guida per l’educazione finanziaria hanno inserito l’edufin all’interno del curricolo di Educazione civica, riconoscendola come parte della cittadinanza economica. È una scelta culturale che risponde a una domanda urgente: come preparare le nuove generazioni a vivere responsabilmente in un’economia sempre più interconnessa e digitale?
Cosa ci dice la ricerca: l’impatto dell’educazione finanziaria
Le prove raccolte negli ultimi anni convergono su un punto: l’educazione finanziaria funziona, e produce benefici tangibili quando è ben progettata. Un’analisi condotta da Kaiser e Menkhoff (2020), su 37 studi sperimentali e oltre 115.000 studenti, dimostra che i programmi scolastici di educazione finanziaria portano a un aumento consistente delle conoscenze economiche e, in misura minore ma significativa, dei comportamenti finanziari positivi. I dati rivelano anche un aspetto interessante: l’efficacia è più alta nella scuola primaria, dove la mente dei bambini è più plastica e i concetti di valore, scelta e responsabilità vengono interiorizzati più facilmente. Inoltre, i programmi più brevi ma intensi – circa 20-40 ore complessive – risultano più produttivi di percorsi troppo estesi o occasionali.
Questi risultati confermano ciò che molti insegnanti sperimentano ogni giorno: la finanza non si insegna solo spiegandola, ma facendola vivere. Le metodologie attive – simulazioni, giochi, esperienze cooperative – sono quelle che meglio aiutano a collegare i concetti economici alla realtà degli studenti. In altre parole, per imparare a gestire il denaro bisogna allenarsi a prendere decisioni, non soltanto ad ascoltare nozioni
Il caso italiano: quando la scuola diventa leva di equità
Un contributo prezioso arriva dal recente studio della Banca d’Italia (2024), che ha valutato in modo rigoroso gli effetti del programma nazionale di educazione finanziaria avviato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’indagine, condotta su oltre 1.500 studenti, mostra che i ragazzi coinvolti in attività guidate da docenti formati e supportati da materiali didattici interattivi abbiano registrato un miglioramento medio dell’alfabetizzazione finanziaria di 8 punti percentuali rispetto al gruppo di controllo.
Non solo: i benefici più evidenti si osservano proprio tra gli studenti provenienti da contesti socio-economici meno favoriti. Questo dato è cruciale, perché dimostra che la scuola può ridurre le disuguaglianze economiche, se accompagnata da un’adeguata formazione del corpo docente. Quando invece il programma viene implementato in modo passivo — ad esempio distribuendo materiali senza accompagnamento formativo — i risultati si riducono sensibilmente e finiscono per avvantaggiare solo chi già dispone di risorse culturali più alte.
La lezione, anche qui, è chiara: l’efficacia dell’educazione finanziaria dipende non solo dai contenuti, ma dalla relazione educativa. Il ruolo dei docenti è insostituibile: la loro capacità di contestualizzare, stimolare il dialogo e rendere accessibili i concetti fa la differenza tra un percorso inclusivo e uno selettivo. Il programma italiano – riconosciuto oggi come una delle best practice europee – mostra che l’educazione finanziaria, quando è strutturata e accompagnata da formazione e monitoraggio, può diventare un potente strumento di cittadinanza.
ESPLORA!
Un passo verso il futuro
Il percorso gratuito di Bper per primaria e secondaria di I e II grado, con stimolanti strumenti didattici digitali per affrontare i temi fondamentali dell’educazione finanziaria.
Quando e come funziona: le condizioni di efficacia
Non basta “parlare di soldi”: serve un approccio attivo, continuo e inclusivo. Le esperienze raccolte a livello internazionale delineano alcune condizioni comuni di successo:
• Integrazione nel curricolo, non come disciplina a sé, ma come chiave trasversale che attraversa matematica, economia, storia e cittadinanza.
• Apprendimento esperienziale, con attività che simulano situazioni di vita reale: gestire un budget, pianificare una spesa, organizzare un progetto scolastico.
• Formazione dei docenti, indispensabile per trasformare la finanza da argomento tecnico a strumento educativo.
• Continuità, perché i programmi episodici hanno effetti limitati e non consolidano abitudini.
• Inclusione, promuovendo linguaggi accessibili, superando stereotipi di genere e rendendo la finanza un terreno comune, non elitario.
Un esempio emblematico viene dalla Finlandia, dove i concetti di risparmio e credito vengono introdotti già nella scuola primaria attraverso storie e giochi cooperativi. Nella secondaria, gli studenti sviluppano progetti imprenditoriali sostenibili e gestiscono bilanci simulati, collegando l’economia al benessere collettivo. La chiave del successo, in tutti i casi, è la connessione tra teoria e vita quotidiana: imparare a pianificare, a risparmiare, a scegliere responsabilmente significa imparare a progettare il proprio futuro.
Casi e modelli dal mondo
In diversi Paesi, l’educazione finanziaria è già parte integrante del curricolo scolastico. Nel Regno Unito, ad esempio, rientra nell’insegnamento di Personal, Social and Economic Education, con laboratori pratici su risparmio e consumo responsabile. In Canada, i moduli provinciali collegano economia e sostenibilità, con progetti di gestione del denaro e finanza etica, mentre il Giappone ha introdotto percorsi di life planning fin dalla primaria, per insegnare la relazione tra denaro, tempo e obiettivi di vita.
La Nuova Zelanda, invece, valorizza l’interdisciplinarità: finanza e benessere personale si intrecciano in percorsi che uniscono matematica, salute e cittadinanza attiva. Tutte queste esperienze condividono una visione comune: la finanza non è solo una questione di numeri, ma un linguaggio per comprendere il mondo e se stessi.
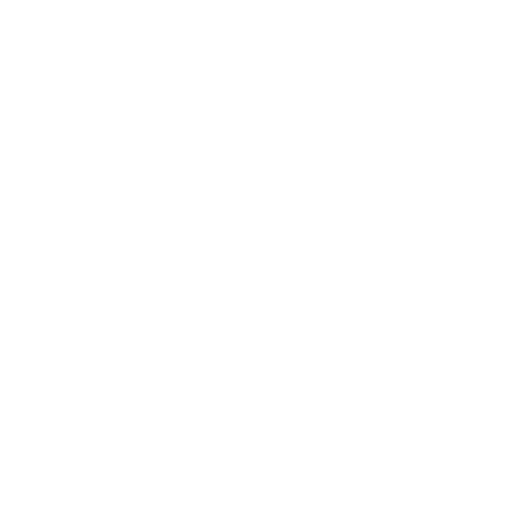
IDEE LABORATORIALI
Asta del risparmio
Simulare le scelte economiche per educare alla consapevolezza finanziaria
Obiettivi didattici
• Comprendere la differenza tra bisogni e desideri
• Riconoscere il concetto di costo opportunità: ogni scelta economica comporta una rinuncia
• Riflettere sull’importanza del risparmio, della pianificazione e del consumo responsabile
• Sviluppare abilità di negoziazione, confronto e decisione consapevole
• Rafforzare le competenze di cittadinanza economica e collaborazione tra pari
Destinatari
Classi della scuola secondaria di primo e secondo grado (attività adattabile anche alla primaria con lessico semplificato).
Durata
1 ora – 1 ora e mezza (a seconda del livello e del numero di “beni” proposti).
Materiali necessari
Scheda o tabella con budget iniziale (es. 100 punti o “monete”).
Elenco di beni o obiettivi con descrizione e valore simbolico:
• smartphone nuovo
• abbonamento streaming
• vacanza con amici
• corso di formazione
• donazione solidale
• fondo emergenze
• risparmio a lungo termine
• mezzo di trasporto
• gadget o spese superflue
• (Facoltativo) Monete o gettoni stampabili per simulare le offerte
• Lavagna o bacheca digitale (es. Padlet, Jamboard, Canva Whiteboard) per tenere traccia delle puntate
Modalità di svolgimento
1. Introduzione (10 minuti)
L’insegnante introduce la situazione: “Ognuno di voi ha 100 monete da spendere in un’asta speciale. Potrete acquistare beni, esperienze o obiettivi personali. Ma attenzione: il budget è limitato e non tutto si può avere”.
Breve discussione: cosa significa “risparmiare”? Cosa distingue un bisogno da un desiderio?
2. L’asta (30–40 minuti)
Gli studenti (singolarmente o a gruppi) fanno offerte per i diversi beni, decidendo quanto spendere e cosa sacrificare. L’insegnante può variare il ritmo dell’asta:in forma classica (alzata di mano o messaggi in chat) o come gioco digitale (con moduli online o app tipo Kahoot!, Mentimeter, Nearpod).
Al termine, ogni gruppo elenca cosa ha “acquistato” e quanto ha speso.
3. Debriefing e riflessione (20 minuti)
Domande guida:
Cosa vi ha spinto a scegliere alcuni beni invece di altri?
Avete deciso di risparmiare? Perché?
Quali emozioni avete provato durante l’asta?
In cosa questa esperienza somiglia alle scelte economiche reali?
Conclusione collettiva: il valore delle scelte non è solo economico, ma anche etico e sociale.
Collegamenti interdisciplinari
Matematica: calcolo percentuali, gestione budget, confronto costi/benefici.
Economia: concetti di risparmio, consumo, pianificazione.
Educazione civica: cittadinanza economica, responsabilità e legalità.
Tecnologia: uso critico delle piattaforme digitali di acquisto e investimento.
Suggerimento metodologico
Chiudi l’attività con una mappa concettuale collettiva dei criteri di scelta emersi (bisogni, desideri, priorità, solidarietà, rischio, risparmio). Può diventare la base per un secondo modulo su “pianificazione del budget familiare” o “economia sostenibile”.
Obiettivo finale
Far sperimentare agli studenti che il denaro è uno strumento di libertà e responsabilità, non un fine. Ogni decisione economica incide sul proprio benessere e su quello collettivo: risparmiare significa anche scegliere con consapevolezza il proprio futuro.
L’educazione finanziaria, quando è inclusiva, partecipativa e orientata alla vita reale, diventa molto più di un modulo didattico: è un laboratorio di cittadinanza. Aiuta i giovani a comprendere le connessioni tra economia, diritti e responsabilità, e a costruire un rapporto equilibrato con il denaro, non come fine, ma come mezzo per il benessere personale e collettivo. Educare alla finanza significa, in fondo, educare alla libertà: la libertà di scegliere con consapevolezza, di partecipare, di contribuire al futuro comune.


